Prof. Giuseppe Nibbi La sapienza poetica e filosofica dell’età tardo-antica 5-6-7 dicembre 2012
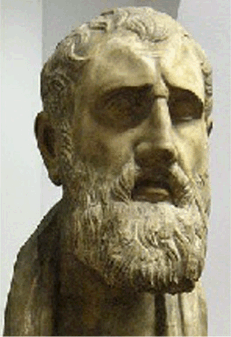
Zenone di Cizio
SUL TERRITORIO DELLA SAPIENZA POETICA E FILOSOFICA DELL’ETÀ TARDO-ANTICA
S’INCONTRA L’EPISTOLARIO A LUCILIO ...
Il nostro viaggio ci ha condotte e ci ha condotti nel vivo del primo paesaggio intellettuale del territorio che stiamo attraversando: da otto settimane siamo in cammino sul territorio della “sapienza poetica e filosofica dell’Età tardo-antica”. Nel cuore di questo paesaggio intellettuale – che prende il nome dalla prima dinastia imperiale romana, la dinastia giulio-claudia [quella di Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone] – siamo state accolte ed accolti, e ci troviamo tuttora in compagnia, di un “classico” della seconda generazione: Lucio Anneo Seneca detto il Filosofo e sappiamo che questo personaggio è residente qui ma non ci abita perché dai primi anni del XIV secolo [del 1300] è domiciliato nel Limbo della Divina Commedia di Dante Alighieri [nel IV Canto dell’Inferno] e non è un privilegio il suo in quanto tutta “la schiera [la bella Scuola] dei Classici” ha trovato collocazione nel Limbo dantesco.
Negli ultimi due itinerari di questo viaggio abbiamo potuto conoscere i tratti fondamentali della vita di Seneca e abbiamo partecipato [con l’ausilio degli Annales di Tacito] al rituale della sua morte che, nei secoli, è stato raccontato e descritto in varie forme artistiche, letterarie e figurative: siete riuscite e riusciti ad osservare il dipinto intitolato “La morte di Seneca” di Jaques-Louis David? [Siete ancora in tempo].
Nelle ultime due settimane abbiamo studiato le caratteristiche delle nove Tragedie, dei dieci Dialoghi e dei tre Trattati di Seneca ma queste opere, sebbene siano molto significative, non sono considerate il vero e proprio capolavoro di Seneca il Filosofo perché la sua opera più importante, uno dei testi più autorevoli dalla Storia del Pensiero Umano, s’intitola Epistulae morales ad Lucilium [Lettere morali a Lucilio o semplicemente Lettere a Lucilio]. Che caratteristiche ha quest’opera? Per prima cosa dobbiamo dire che è un Epistolario [sono Lettere] e questa affermazione ci fa subito venire in mente il fatto che in questo momento a Roma c’è anche uno scrittore di Lettere di nostra conoscenza che si chiama Paolo di Tarso il quale ci ha dato appuntamento nella capitale dell’Impero [lui era convinto di arrivare a Roma a spese dello Stato e c’è riuscito] quando lo abbiamo salutato ai primi di giugno del 2011, alla fine del viaggio nel territorio della “sapienza poetica ellenistica di stampo evangelico”[del 2010-2011], circa un anno e mezzo fa. Lucio Anneo Seneca e Paolo di Tarso vivono a Roma nello stesso periodo di tempo: si sono incontrati, hanno dialogato tra loro? Sapete già che intorno a questa ipotesi è nata una letteratura, e tra le studiose e gli studiosi di filologia c’è un dibattito in corso su questo tema che dura da secoli e che periodicamente riemerge, ma procediamo con ordine.
Ci stavamo chiedendo: che caratteristiche ha il capolavoro di Seneca intitolato Epistulae morales ad Lucilium [Lettere a Lucilio]? Quest’opera è dedicata all’amico e discepolo Lucilio, magistrato e procuratore in Sicilia nel 63 e nel 64. Lettere a Lucilio [Epistulae morales ad Lucilium] è un capolavoro [un oggetto di raffinato artigianato intellettuale] perché è un’opera che, per la prima volta e in modo diretto nella Letteratura latina, descrive la vita interiore – i pensieri più intimi, i ragionamenti più profondi, le riflessioni più confidenziali, le inquietudini – di una persona del I secolo che vive in un particolare periodo di crisi morale, sociale e politica. Questa persona è angosciata dal fatto di non sapere come fare a venirne fuori dalla crisi: ha moltissime idee da proporre come intellettuale, soprattutto sul piano educativo, ma chi lo ascolta, chi è disposto ad ascoltarlo quando chi gestisce il potere ne ha decretato l’isolamento e pretende da lui il silenzio?
Seneca scrive le Lettere a Lucilio negli anni in cui viene costretto a ritirarsi a vita privata [dal 62]: l’Epistolario senechiano è composto da 124 Lettere divise in venti libri che probabilmente non ci sono pervenute tutte perché Aulo Gellio testimonia la presenza di un ventiduesimo libro. Formalmente i testi delle Lettere a Lucilio rispettano, almeno in parte, i canoni del genere epistolare, non sono però lettere private, non danno e non chiedono notizie, ma piuttosto sollecitano la meditazione ed invitano ad un dialogo a distanza che non prevede l’obbligo formale della risposta scritta. L’Epistolario a Lucilio contiene un’ampia riflessione di carattere fìlosofico-morale su una serie di temi fondamentali: l’immortalità dell’anima, il sommo bene, la funzione della filosofia, la provvidenza divina, le passioni, l’amicizia, la malattia del corpo e dell’anima, l’esperienza dell’esilio, il contrasto tra odio e amore, la relazione tra il sonno e il sogno, il trionfo della morte [in questo elenco riconosciamo parole che ci sono note e che appartengono al catalogo dei termini con cui ha inizio la fine dell’Età antica]. Nelle Lettere a Lucilio non mancano naturalmente osservazioni sulla vita dell’epoca, commenti su avvenimenti di particolare interesse, critiche riguardanti la Letteratura.
Le Lettere a Lucilio costituiscono la summa del pensiero filosofico di Seneca e il fatto importante è che il filosofo questo pensiero lo concepisce soprattutto effettuando un’indagine su se stesso ed esorta il suo amico perché si dedichi anche lui ad esplorare la sua vita interiore, quindi, non si tratta di un pensiero organizzato in un sistema ma bensì di un percorso intellettuale in divenire: compie i suoi primi passi quella che è stata chiamata la “filosofia dinamica”, un indirizzo che crea un pensiero da tradurre in vita vissuta perché la filosofia non deve servire soltanto per descrivere il mondo [precisa Seneca] ma deve essere uno strumento utile per cambiare il mondo. Nelle Lettere a Lucilio Seneca non tratta mai di politica né di fatti politici e per questo motivo l’opera non assume un carattere documentario come l’Epistolario di Marco Tullio Cicerone. Seneca tace quasi completamente sulla sua vita passata e sulle sue eccezionali esperienze perché i ricordi sono diventati riflessioni e queste riflessioni coinvolgono una problematica più ampia e più complessa che va oltre i fatti e i personaggi coinvolti. Nel testo di ogni Lettera ci sono ragionamenti – tradotti, per iscritto, in veri e propri aforismi – che danno vita ad una saggezza inquieta, spesso autocritica, mai appagata con risposte precostituite, e questa è la caratteristica più significativa che emerge dalla scrittura di Seneca: questa “saggezza inquieta, autocritica, mai paga e sempre in ricerca” è il primo elemento rilevante che qualifica l’importanza educativa della filosofia dell’Età tardo-antica che vorrebbe concretamente insegnare alla persona a padroneggiare i moti dell’animo per governare l’agitazione, la smania, il nervosismo, la trepidazione generate da un periodo di crisi morale, materiale, spirituale come quello dell’Epoca giulio-claudia.
REPERTORIO E TRAMA ... per dieci minuti al giorno di lettura e di scrittura:
In quale circostanza avete avuto occasione di essere persone agitate, smaniose, nervose, trepidanti?… Quando, come e perché è subentrata in voi l’agitazione o vi è presa la smania o vi è venuto il nervoso o è comparsa la trepidazione ?…
Scrivete quattro righe in proposito perché riflettere sui moti del proprio animo è motivo di saggezza, e Seneca il Filosofo ci ricorda che la saggezza deve essere “inquieta, autocritica, mai paga e sempre in ricerca”…
Adesso dovremmo leggere l’incipit delle Lettere a Lucilio – la prima Lettera del primo Libro – ma siccome il testo di questa Lettera tratta di un argomento con il quale dovremo fare i conti più avanti, quando si farà vivo Paolo di Tarso che in questo momento si trova agli arresti domiciliari in attesa di un processo nel quale viene assolto e, quindi, torna ad essere un libero cittadino – anche se il peggio, per lui e per Seneca, deve ancora venire –, ebbene, allora rimandiamo la lettura della Lettera con cui inizia l’Epistolario morale di Seneca, anche perché noi abbiamo un altro appuntamento che non possiamo disertare.
Infatti, prima di continuare ad occuparci delle Lettere a Lucilio, dobbiamo aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura perché le considerazioni che abbiamo fatto rimandano all’autore di un romanzo del quale stiamo leggendo dei brani, e il nostro incontro con lo scrittore viennese Stefan Sweig – che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane – non è casuale perché il pensiero contenuto nelle opere di questo intellettuale mitteleuropeo del primo Novecento è attinente alla riflessione di Seneca, e anche Sweig coltiva una “saggezza inquieta, autocritica, mai paga e sempre in ricerca” e compie questa operazione mettendo spesso alla prova, con un certo cinismo, i personaggi dei suoi romanzi.
La signora Irene Wagner – la protagonista del romanzo Paura, del quale stiamo leggendo brani molto significativi – rappresenta una classica metafora con la quale l’autore vuole concretamente mostrare come sia difficile governare l’agitazione, la smania, il nervosismo, la trepidazione, quando sono generate anche da un periodo di crisi morale, materiale e spirituale come quello che sta vivendo l’Europa scombussolata dall’ascesa al potere [a furor di popolo] dei grandi dittatori. Nel romanzo-breve che stiamo leggendo – che s’intitola Paura e che è stato scritto nel 1925 – Stefan Zweig ci conduce nell’animo travagliato di una signora [una figura metaforica], Irene Wagner, che ha tradito il marito per noia più che per passione, e che di colpo si ritrova perseguitata da un’arpia [come nelle tragedie di Euripide e di Seneca] che la ricatta [conosciamo la storia] e lei è costretta a pagare quell’essere orrendo che non molla la presa: in Irene cresce la vergogna, l’ansia di perdere la sua vita comoda e leggera, i figli, il marito che è la fonte della sua agiatezza. Irene è in preda all’agitazione, alla smania, al nervosismo, alla trepidazione [dovrebbe leggere le Lettere a Lucilio e fra poco la inviteremo a farlo con noi questo esercizio].
Irene vive “in uno stato d’animo crepuscolare”, si sente braccata, disperata, pensa di essere perduta: eppure avverte anche che solo ora inizia a comprendere e ad amare le persone che la circondano, le strade di Vienna, gli attimi reali dell’esistenza, ora che tutto sta per essere inghiottito dal buio della morte. Il marito avvocato le racconta – nel corso di un episodio nel quale sono coinvolti i figli della coppia – alcuni casi processuali dai quali emerge una dolorosa situazione che lei sta sperimentando: il colpevole soffre più per la paura di essere scoperto, per l’ansia di dover nascondere il reato, che non per il terrore del castigo, e la pena, anzi, diventa desiderabile perché è catartica [purificatrice], e Irene comincia a pensare che il racconto del marito sia un tacito invito alla confessione e lei rimugina sul fatto che se si decidesse a confessare potrebbe liberarsi e riscattarsi, ma come e da dove [a quali principi] attingere per trovare il coraggio di confessare? Sappiamo [perché abbiamo studiato questo argomento] che lo stesso concetto – sul valore catartico della confessione e della pena – è stato espresso anche da Seneca nel testo della tragedia Tieste.
E ora leggiamo dal testo di questo romanzo – che si presenta come una tragedia di stampo senechiano scritta in lingua corrente – alcune pagine.
LEGERE MULTUM….
Stefan Zweig, Paura
Era come se fino a quel momento Irene avesse proceduto nella vita solo a tentoni, in uno stato d’animo crepuscolare, con gli occhi semichiusi, mentre ora, all’improvviso, ogni cosa brillava dall’interno, terribilmente bella in tanta chiarezza. Lì davanti a lei, a portata di mano, vi erano oggetti e realtà di cui non s’era mai occupata e in merito ai quali capiva adesso che rappresentavano la sua vita vera; altri, invece, che prima le erano sembrati importanti, si volatilizzavano come fumo. Aveva avuto sinora relazioni sociali molto intense, in mezzo al frastuono, alle chiacchiere, circondata da persone facoltose, e in fondo era vissuta soltanto per questo; ma adesso, chiusa da una settimana nel carcere della propria casa, non ne sentiva la mancanza, anzi provava soltanto disgusto per la vacua operosità della gente inoperosa - e d’istinto misurava sul metro di questo primo e forte sentimento, che solo ora le era dato provare, la superficialità delle sue precedenti inclinazioni e l’incalcolabile perdita che aveva subìto in fatto di amore attivo. Come in un abisso guardava nel suo passato. In otto anni di matrimonio, nell’insensata convinzione di godere d’una felicità troppo modesta, non aveva mai cercato di avvicinarsi al marito, rimanendo estranea all’animo di lui, non meno che ai figli. Tra lei e i bambini c’era gente stipendiata. Governanti e domestici per dispensarla da tutte quelle piccole incombenze, di cui cominciava ad avvertire solo ora - da quando aveva guardato meglio nella vita dei figli - che potevano essere più incantevoli degli sguardi vogliosi degli uomini e più inebrianti di un amplesso. A poco a poco la sua vita acquistò un nuovo senso: fra le cose si strinse una rete di rapporti, e in tutto ella ravvisò subitamente il lato serio e significativo. Da quando conosceva il pericolo, e con il pericolo un sentimento vero, aveva di colpo cominciato a percepire che qualsiasi cosa, anche la più estranea, le era affine. In tutto si ritrovava; e il mondo, prima trasparente come vetro, divenne all’improvviso uno specchio grazie alla macchia scura della sua ombra. Ovunque volgesse lo sguardo e tendesse l’orecchio: ecco d’improvviso la realtà. …
I giornali riportavano la vicenda di un ufficiale che, sotto ricatto, era diventato un traditore. Un brivido la scosse. Come lo capiva! Non avrebbe fatto anche lei l’impossibile per procurarsi del denaro, per comprarsi qualche giorno di pace, una parvenza di felicità? Qualsiasi riga accennasse al suicidio, al delitto, alla disperazione adesso improvvisamente la toccava nel profondo. In tutti si riconosceva: in colui che era stanco di vivere o aveva perso ogni speranza, nella domestica sedotta e nel bambino abbandonato, ovunque ritrovava il suo destino. Di colpo comprese quanto fosse ricca la vita, ed ebbe la certezza che mai più la sorte le avrebbe inflitto un’unica ora di vacuità e adesso, solo adesso che tutto volgeva al termine, avvertiva come possibile un nuovo inizio. E su quella sublime armonia con l’infinità del mondo doveva mai esser consentito che la sordida donnaccia mettesse le sue zampe per farne strame? E per quell’unica sua colpa doveva andar distrutta l’intera grandezza e bellezza che ora, per la prima volta, lei si sentiva capace di comprendere? E perché - si ribellava ciecamente contro una sventura che in fondo riteneva giustificata -, perché proprio a lei doveva toccare una pena tanto terribile per una mancanza di così poco conto? Quante altre lei conosceva - donne frivole, sfrontate, lussuriose -, che arrivavano a pagarli, i loro amanti, nelle cui braccia si facevano beffe dei mariti: donne che vivevano nella menzogna come nel loro elemento, che nel fingere diventavano più belle, più forti se braccate, più sagge nel pericolo, mentre lei crollava senza forze al primo moto di paura, alla prima trasgressione. Ma era davvero colpevole? Nel profondo del cuore sentiva che quell’uomo, il suo amante, le era estraneo, che lei non gli aveva mai dato nulla della sua vita vera. Nulla aveva ricevuto da lui, di nulla gli aveva fatto dono. Tutto ciò che era stato, e già caduto nell’oblio, non era un delitto ascrivibile a lei, bensì a un’altra donna che lei stessa non comprendeva e che nemmeno riusciva più a ricordare. Era legittimo punire qualcuno per un delitto ormai espiato con il passare del tempo? Ebbe un subitaneo moto di sgomento: sarebbe stato capace, il marito, di comprendere che lei non aveva amato un uomo, bensì l’avventura? Che anche lui era colpevole per la sua troppa bontà, per averle offerto una vita senza affanni, nella quale il carattere le si era infiacchito? Avrebbe saputo essere altrettanto giusto, dovendo giudicare qualcosa che lo riguardava in maniera diretta?
Ma era destino che Irene non potesse abbandonarsi a queste dolci speranze perché già l’indomani arrivò un nuovo biglietto e, come una scudisciata, ravvivò la sua paura, che si era un poco sopita. Questa volta la richiesta era di duecento corone, e lei le consegnò senza alcuna resistenza. Era terrorizzata da quel ricatto tutto giocato al rialzo, al quale sentiva di non poter far fronte nemmeno sul piano materiale, perché - anche se di famiglia facoltosa - non era certo in condizioni di procurarsi somme considerevoli senza che nessuno lo notasse. E poi, a cosa mai sarebbe servito? Sapeva che l’indomani sarebbero state quattrocento corone, e prima o poi mille, e quanto più denaro le avesse dato, tanto più quell’altra gliene avrebbe chiesto, e poi alla fine, non appena lei avesse esaurito le risorse, sarebbe arrivata la lettera anonima, la catastrofe. Ciò che comprava era solo un po’ di tempo, la possibilità di tirare per un attimo il fiato, due o tre giorni di tregua, magari una settimana, ma comunque un tempo affatto inutile, gonfio di tormenti e di tensione.
Da settimane dormiva male per via di sogni ancora più angoscianti della veglia, le mancavano l’aria, il movimento, un po’ di requie, un’occupazione. Non riusciva più a leggere, a intraprendere alcunché, braccata dalla paura come da un demone. Le pareva d’essere un’inferma. Talvolta doveva mettersi a sedere di colpo, perché colta da violente palpitazioni, il peso dell’ansia le inondava le membra con il liquido denso di una stanchezza quasi dolorosa, che però non cedeva al sonno. La sua intera esistenza era minata da quella paura che la divorava, il suo corpo ne era intossicato, e in cuor suo ella chiedeva solo che il morbo si scatenasse infine in una sofferenza palese, in una malattia suscettibile di riscontro clinico, per la quale gli altri provassero comunque misericordia e pietà. …
Anche il marito era cambiato nell’ultimo periodo. La severità minacciosa dell’approccio inquisitorio, assunto nei primi giorni, si era ammorbidita in un particolare atteggiamento benevolo e premuroso che, suo malgrado, la riportava al tempo in cui erano fidanzati: la trattava come fosse malata, usandole riguardi che la confondevano, perché si vergognava di quell’amore così immeritato. Ma d’altra parte la preoccupavano, perché potevano essere anche solo uno stratagemma per carpirle in modo surrettizio il segreto dalle mani indebolite, proprio quando lei meno se lo aspettava. Da quella notte in cui l’aveva spiata nel sonno, e da quel giorno in cui le aveva visto in mano la lettera, la sua diffidenza si era volta in compassione, cercava di guadagnarsi la fiducia di lei con una delicatezza che a volte la tranquillizzava e quasi la induceva a cedere, per tornare a consegnarla un attimo dopo al sospetto. E se fosse stata solo un’insidia del giudice istruttore, l’adescamento di chi vuol portare fuori strada l’imputato, un ponte mobile della fiducia che lei avrebbe attraversato sino alla confessione, ma che poi sarebbe stato rimosso all’improvviso, per lasciarla alla mercé del suo arbitrio? Oppure sentiva anche lui che quel continuo spiare e origliare non era più tollerabile, e l’affetto che provava per Irene era così profondo da indurlo in segreto a condividerne il dolore, che di giorno in giorno si palesava sempre più?
Assalita da uno strano brivido, aveva come la percezione che lui talvolta le stesse offrendo la parola capace di redimerla, che volesse renderle la confessione di una facilità quasi allettante; Irene capiva le sue intenzioni, e tanta bontà la colmava di gioiosa gratitudine. Ma, quanto più vivo si faceva l’affetto per il marito, tanto più cresceva la vergogna - una vergogna inflessibile nell’impedirle di pronunciare la parola dovuta, ben più di quanto non lo fosse stata prima la diffidenza. Una volta, in quei giorni, lui le parlò con molta chiarezza e guardandola negli occhi. Lei stava rincasando e aveva sentito discutere ad alta voce nell’ingresso: il tono energico e tagliente del marito, i rimproveri queruli della governante e, a intervalli, lacrime e singhiozzi. La sua prima reazione fu di sgomento. Se in casa sentiva alzare la voce o parlare con foga, la coglieva subito un brivido. La paura era il sentimento con cui reagiva a tutto ciò che le sembrava insolito, la paura bruciante che la lettera fosse già arrivata e il segreto svelato.
Ogni volta che apriva la porta rientrando, il suo primo sguardo correva interrogativo ai volti, per scoprire se durante quelle ore fosse accaduto qualcosa, se la catastrofe si fosse già abbattuta in sua assenza. In questo caso, come constatò subito con grande sollievo, si era trattato solo di un bisticcio fra i bambini davanti a una specie di piccolo tribunale improvvisato. Pochi giorni prima una zia aveva fatto dono di un giocattolo al maschietto, un cavalluccio dai colori vivaci, il che aveva acceso un’aspra invidia nella sorellina, il cui regalo non era altrettanto bello. La piccola aveva cercato inutilmente di far valere i propri diritti e con una tale bramosia che il fratello le aveva proibito di avvicinarsi al suo giocattolo - suscitando così nella bambina, sulle prime, grida di collera e poi un silenzio sordo, cupo, ostinato. Ma l’indomani il cavallo era sparito senza lasciare traccia, e tutte le ricerche del ragazzino furono vane finché, per puro caso, l’oggetto scomparso non fu rinvenuto, a pezzi, nella stufa: le parti in legno spezzate, il manto strappato via e l’interno sventrato. I sospetti caddero, come naturale, sulla piccola; il bambino era corso in lacrime dal padre per accusare l’infame, la quale fu costretta a dare spiegazioni - e stava giusto cominciando l’interrogatorio. Irene provò un’improvvisa gelosia. Come mai i bambini andavano sempre da lui e mai da lei, a raccontare i loro affanni? Da sempre confidavano i loro bisticci e le loro lagnanze a suo marito; finora le aveva fatto piacere essere sollevata da questi piccoli fastidi, ma adesso tutto d’un tratto desiderava con ardore poter partecipare perché sentiva che erano segno di amorevole confidenza. Il breve dibattimento si concluse in fretta. Sulle prime la piccola negò con un tremito nella voce che la tradiva. Irene guardava il marito. Le pareva che lui presiedesse quel tribunale domestico non per giudicare la bambina, bensì lei stessa, il suo destino, in quanto già l’indomani le sarebbe potuto accadere di ritrovarsi lì alla sbarra, con la stessa voce tremante e concitata. L’uomo mantenne uno sguardo severo finché la piccola continuò a insistere nella sua bugia, quindi ne smontò parola per parola la resistenza, senza mai andare in collera se la figlia si intestardiva. Poi però, quando il negare si perse in una sorda ostinazione, le parlò in tono bonario, dimostrandole addirittura l’intima necessità del suo atto, e quasi la scusò di aver compiuto un gesto tanto riprovevole in un accesso d’ira, perché di certo non si era resa conto che, con la sua condotta, avrebbe causato un dolore al fratello. E fu così affettuoso e persuasivo nello spiegare alla bambina, sempre meno sicura di sé, per quale motivo il suo atto fosse qualcosa di comprensibile e tuttavia di condannabile, che alla fine la piccola rese, balbettando, la sua confessione. Irene si gettò su di lei per abbracciarla, ma la piccola la respinse con un moto di stizza. Anche il marito la biasimò per quella pietà intempestiva, poiché non intendeva affatto lasciare impunita la cattiva azione, e comminò una pena, in sé di poco conto, ma che avrebbe toccato nel profondo la figlia, ovvero il divieto di partecipare l’indomani a una festicciola, in vista della quale la piccola si rallegrava già da settimane. La bambina ascoltò la sentenza fra i singhiozzi; il fratello proruppe in grida di giubilo, ma quello scherno astioso e avventato gli procurò subito la medesima punizione, e a causa della sua gioia maligna si proibì anche a lui di partecipare alla festicciola. Mesti, non avendo altra consolazione che quella di condividere il medesimo castigo, i bambini infine si allontanarono, e Irene restò sola con il marito. Adesso, tutto d’un tratto lo sentì, era infine giunto il momento di parlare della propria colpa, invece che alludervi soltanto, discorrendo di quella della bambina e della sua confessione, ed ella fu colta da un senso di sollievo al pensiero di poter aprire il suo cuore e chiedere pietà almeno in forma velata. Perché sarebbe stato un segnale per lei, se l’uomo avesse accolto con atteggiamento benevolo la sua intercessione per la bambina: sapeva che in tal caso avrebbe forse trovato il coraggio di perorare la propria causa. «Dimmi Fritz,» esordì «davvero non vuoi lasciare andare i bambini alla festa domani? Ne saranno terribilmente infelici, soprattutto Helène. Ciò che ha fatto non è poi così grave. Perché vuoi punirla con tanta severità? Non ti fa pena la povera piccina?». Lui la guardò. Poi si mise a sedere con assoluta calma. Si vedeva che desiderava affrontare la questione fin nel dettaglio, e un presentimento, piacevole e angosciante insieme, le fece sospettare che l’avrebbe ripagata, parola per parola, senza sconti; tutto il suo essere attendeva la fine di quella pausa che lui, forse con intenzione oppure perché occupato a riflettere, faceva durare così a lungo. «Se non mi fa pena? mi chiedi. E io ti rispondo: no, oggi non più. Adesso che ha ricevuto il castigo sarà sollevata, anche se le sembrerà duro. Infelice, piuttosto, lo era ieri - quando il povero cavallino languiva a pezzi nella stufa, tutti in casa lo stavano cercando e, di ora in ora, cresceva in lei la paura che potessero trovarlo, che lo trovassero davvero. La paura è peggio del castigo; perché alla fine il castigo è qualcosa di determinato e, sia pesante o meno, è sempre meglio della spaventosa incertezza, della tremenda tensione che si prolunga all’infinito. Appena seppe qual era il castigo, ne fu sollevata. Le sue lacrime non devono indurti in errore: è solo che adesso sgorgano, mentre prima se le teneva dentro. E dentro fanno soffrire di più che fuori. Se non fosse una bambina o se si potesse in qualche modo scandagliare il suo cuore, si scoprirebbe - credo - che è davvero felice, nonostante la punizione e le lacrime, più felice di ieri quando girava per casa in apparenza spensierata e senza che nessuno la sospettasse». Irene alzò gli occhi. Aveva la sensazione che ogni parola fosse indirizzata a lei. Ma lui sembrava ignorarla e, fraintendendone forse lo sguardo, seguitò risoluto: «È proprio così, puoi credermi. Lo vedo in tribunale e durante l’istruttoria. Ciò che più di tutto fa soffrire gli imputati è dover dissimulare, il rischio di essere scoperti, la spaventosa necessità di difendere una menzogna contro migliaia di piccoli attacchi occulti. È terribile trovarsi di fronte a un caso del genere, in cui il giudice ha già tutto in mano, la colpa, la prova, magari persino la sentenza, manca solo la confessione, che è bloccata giù nel profondo dell’imputato e non vuole uscire, per quanto uno tiri e stappi. Talvolta la sofferenza dei giudici è maggiore, rispetto a quella delle vittime. Tanto più che gli imputati vedono sempre nel giudice un nemico, mentre è proprio lui che li aiuta. E io, l’avvocato, il difensore, dovrei esortarli a non confessare, a sostenere con sempre nuovi argomenti le loro menzogne, ma spesso in cuor mio non ne ho il coraggio, perché i colpevoli soffrono di più se non confessano, rispetto a quando invece lo fanno e ne ricevono la giusta punizione. Continuo a non capire come si possa commettere un misfatto con la consapevolezza del pericolo, e poi non si abbia il coraggio della confessione. Questa paura meschina davanti a una parola, io la trovo più deplorevole di qualsiasi crimine». «Ma tu credi che sia sempre soltanto paura ciò che blocca gli altri? Non potrebbe essere vergogna, la vergogna di aprire il proprio cuore, di spogliarsi davanti a tutti?».
Sorpreso, egli alzò lo sguardo. Non era avvezzo a ricevere risposte da lei. Ma quella parola lo aveva affascinato. «Vergogna, dici …». Si era alzato in piedi, in preda a una singolare eccitazione, e andava su e giù per la stanza. Quell’idea pareva avesse colpito in lui qualcosa che adesso gli guizzava dentro e si agitava con violenza. D’un tratto si fermò. «Questo lo ammetto…vergogna davanti alla gente che divora insaziabile le disgrazie altrui sbattute in prima pagina». … «Forse» e dovette distogliere lo sguardo perché lui la guardava fisso e lei sentiva che le tremava la voce «forse la vergogna è maggiore al cospetto di coloro cui ci si sente più legati». Lui si fermò di colpo, come immobilizzato da una forza interna. «Tu pensi dunque…» e tutto d’un tratto la sua voce mutò, divenne morbida e soffocata «tu pensi che per Helène sarebbe stato più facile confessare a qualcun altro la sua colpa, magari alla governante». «Sono persuasa che proprio a te ha opposto tanta resistenza solo perché il tuo giudizio ha per lei maggior valore, perché è te che ama più di tutti». Lui si fermò di nuovo. «Forse hai ragione, anzi, senz’altro, però che strano, non ci avevo mai pensato, eppure è così semplice. Forse sono stato troppo severo, tu d’altronde mi conosci …voglio dire, non sotto questo aspetto. Ma adesso vado subito da lei, naturalmente può andare alla festa. Volevo solo punirla per la sua caparbietà, per la sua resistenza, e perché non aveva fiducia in me. Ma hai ragione, non voglio che tu mi creda incapace di perdonare, non lo vorrei, soprattutto non vorrei che lo credessi tu, Irene». Lui la guardò e lei si sentì arrossire sotto il suo sguardo. C’era un’intenzione dietro le sue parole, oppure si trattava solo di un caso, un caso pieno di rischi e di insidie? Irene, nel più segreto recesso di sé, già attendeva con ansia ciò che fino allora aveva temuto, il fulmine liberatore: la scoperta della verità. E il suo desiderio si sarebbe realizzato più in fretta di quanto lei non immaginasse. …
Abbiamo detto che la signora Irene dovrebbe leggere le Lettere a Lucilio e la invitiamo a farlo insieme a noi questo esercizio.
Dobbiamo sapere che dall’Epistolario a Lucilio redatto da Seneca, che è un filosofo di Scuola stoica, è possibile tuttavia ricavare un ampio ventaglio di affermazioni appartenenti alla cultura epicurea: ciò dimostra che l’Età tardo-antica è tempo di integrazione intellettuale [si è decisamente compiuta l’integrazione tra la cultura greca e la civiltà romana, un tema che abbiamo studiato nel nostro viaggio precedente] e il pensiero eclettico di Cicerone ha fatto scuola, perché – per dirla in parole povere – di ciò che è utile sul piano etico non si butta via nulla ma lo si introduce, con spirito pratico, nella propria riflessione filosofica. E Seneca – molto opportunamente [perché bisogna essere uniti nella lotta contro i tiranni] – mette in secondo piano i contrasti, all’origine radicali, tra le varie Scuole ellenistiche [ciniche, epicuree, stoiche, scettiche], e opera per trovare i punti di unione, specialmente nell’etica, a vantaggio di una verità che la compresenza di voci diverse non confonde ma rende più forte.
Seneca nelle Lettere a Lucilio non cita mai né Claudio, né Nerone, né altri personaggi di potere ma mette al centro la sua persona non per esaltarsi narcisisticamente ma per condurre, invece, un’impietosa autocritica verso se stesso e questo suo modo di agire lo sintetizza in un’espressione che è diventata l’emblema della Scuola filosofica stoica romana: «Si è saggi quando si sa liberare se stessi di fronte a se stessi».
Sarebbe bello leggere i testi di tutte le 124 Lettere dell’opera epistolare di Seneca e questo esercizio – per il quale occorrono tempi extrascolastici – lo potete fare per conto vostro: è una lettura che presenta delle difficoltà ma non sono insormontabili perché le molte edizioni in cui quest’opera è stata pubblicata [e che potete richiedere in biblioteca] presentano tutte un buon corredo di note che facilitano la comprensione del testo quando in esso si presentano situazioni che devono essere spiegate perché l’autore non si sofferma a chiarire questioni che il suo lettore, Lucilio, conosce.
Il bello è che – come quasi sempre succede con le opere dei classici – da questo testo, nel corso dei secoli, sono stati estrapolati frammenti significativi [sono stati fatti degli “assaggi” ci ha insegnato Montaigne nel 1580] che hanno assunto la forma dell’aforisma: sapete che cos’è un aforisma? Un aforisma è una sentenza, un motto, una massima, un detto, un precetto, un adagio, una frase significativa che invita alla riflessione. Sono state composte quindi molte “Raccolte di aforismi” tratti dalle Lettere a Lucilio di Seneca e il fatto significativo è che i primi che si sono dedicati a fare questa operazione editoriale sono stati i Padri della Chiesa a cominciare da Gerolamo perché hanno ravvisato in questi detti una precettistica, sebbene stoico-epicurea [quindi pagana], utile per educare e per formare coscienze cristiane. Gli aforismi tratti dalle Lettere a Lucilio di Seneca – nel medioevo, nel rinascimento, in età moderna, in età contemporanea – hanno funzionato come efficaci suggerimenti e come imperdibili occasioni per riflettere sulla condizione umana [Nella prima metà del ‘500 anche Annibal Caro traduce le Lettere a Lucilio e ne raccoglie gli aforismi].
E ora noi ci avvaliamo di una di queste Raccolte per leggere – in chiave aforistica – le Lettere a Lucilio di Seneca. Leggiamo la prima parte di questa “Raccolta di sentenze” che suggeriscono una riflessione sulla condizione umana: sono affermazioni, in qualche caso, non immediatamente facili da capire, tuttavia sono aperte anche all’interpretazione personale perché, mentre lo stoicismo ellenistico originario [del III secolo a.C.] è dogmatico, la visione romana di Seneca della dottrina stoica è decisamente interlocutoria e intrisa di spirito pratico.
LEGERE MULTUM….
Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio [Epistulae morales ad Lucilium]
Raccolta di aforismi come spunti per riflettere sulla condizione umana …
Si è saggi quando si sa liberare se stessi di fronte a se stessi.
Certi momenti ci vengono portati via, altri sottratti e altri ancora si perdono nel vento. Ma la cosa più vergognosa è perder tempo per negligenza.
Della nostra esistenza buona parte si dilegua nel fare il male, la maggior parte nel non far niente e tutta quanta nell’agire diversamente dal dovuto.
Ecco il nostro errore: vediamo la morte davanti a noi e invece gran parte di essa è già alle nostre spalle: appartiene alla morte la vita passata.
Metti a frutto ogni minuto; sarai meno schiavo del futuro se ti impadronirai del presente. Tra un rinvio e l’altro la vita se ne va.
Chi è dappertutto, non è da nessuna parte.
Non comprare troppi libri: dal momento che non puoi leggere tutti i volumi che, per cupidigia, vorresti avere, basta possederne quanti puoi leggerne.
Povero non è chi ha poco, ma chi vuole di più.
Mi domandi quale sia la giusta misura della ricchezza? Primo avere il necessario, secondo quanto basta.
Con un amico decidi tranquillamente di tutto, ma prima decidi se è un amico: una volta che hai fatto amicizia, ti devi fidare; prima, però, devi decidere se è vera amicizia.
Rifletti a lungo se è il caso di accogliere qualcuno come amico, ma, una volta deciso, accoglilo con tutto il cuore e parla con lui apertamente come con te stesso.
Chi ha paura di essere ingannato insegna a ingannare e i suoi sospetti autorizzano ad agire disonestamente.
Certe cose proprio per questo sono meno da temere, perché fanno molta paura. Nessun male è grande se è l’ultimo.
Non può vivere una vita serena chi si preoccupa troppo di prolungarla e annovera fra i grandi beni i molti anni vissuti.
I più ondeggiano infelici tra il timore della morte e le angosce della vita: non vogliono vivere, né sanno morire.
Possedere un bene non serve a niente se non si è pronti a perderlo. E i beni la cui perdita è più facilmente tollerabile sono quelli che, perduti, non possono essere oggetto di rimpianto.
La sorte non ha innalzato nessuno tanto da non ritorcere contro di lui quanto gli aveva concesso di fare. Non fidarti della momentanea bonaccia: fa presto il mare ad agitarsi; nello stesso giorno le barche affondano là dove si erano spinte per diporto.
Chi si adatta bene alla povertà è ricco.
Bisogna essere nell’intimo completamente diversi dagli altri, ma simili al resto della gente nell’aspetto esteriore.
È grande chi usa vasellami di argilla come se fossero di argento, ma non lo è meno chi usa l’argento come se fosse argilla; solo i deboli non sono in grado di reggere la ricchezza.
Non dà gioia il possesso di nessun bene se non puoi dividerlo con altri.
Ritirati in te stesso per quanto puoi; frequenta le persone che possono renderti migliore e accogli quelli che puoi rendere migliori.
Il destino di una persona salita tanto in alto è precipitare.
La persona saggia è autosufficiente non nel senso che vuole essere senza amici, ma che può stare senza amici; e questo “può” significa che, se perde un amico, sopporta con animo sereno.
Chi è diventato amico per convenienza, per convenienza finirà di esserlo. Se nell’amicizia si ricerca un utile, per ottenerlo si andrà contro l’amicizia stessa.
Il sommo bene, cioè la felicità, non cerca al di fuori mezzi per realizzarsi; è un bene interiore e nasce tutto da se stesso; diventa schiavo della sorte se ricerca una parte di sé all’esterno.
Nessuno è tanto vecchio da non poter sperare in un altro giorno di vita. E un solo giorno è un momento della vita.
È veramente felice e padrone di sé chi aspetta il domani senza preoccupazione; se uno dice: “Ho vissuto”, ebbene, ogni giorno alzarsi al mattino gli appare come un guadagno.
Il valore, quando è sfidato, si moltiplica.
Sono più le cose che ci spaventano di quelle che ci minacciano effettivamente, e spesso soffriamo più per le nostre paure che per la realtà.
Crediamo facilmente alle supposizioni; non mettiamo a fuoco le cause delle nostre paure e non ce le scuotiamo di dosso; ci agitiamo e voltiamo le spalle come soldati che abbandonano l’accampamento per il polverone sollevato da un branco di pecore in fuga.
Tutto ciò che è incerto è in balia delle congetture e dell’arbitrio di un animo terrorizzato. Perciò niente è così dannoso, così irrefrenabile come il panico; le altre forme di timore sono irrazionali, questa è dissennata.
Anche la sfortuna è mutevole. Forse sarà, forse non sarà, nel frattempo non è; tu spera nel meglio.
La persona saggia non provocherà mai l’ira dei potenti, anzi la eviterà, come in navigazione si evitano le tempeste.
Nessuno versa il sangue di un altro per il gusto di uccidere, o almeno pochi; la maggior parte agisce più per calcolo che per odio.
Nessuno può vivere felicemente e neppure in maniera tollerabile senza l’amore della saggezza: una perfetta saggezza rende felice la vita, ma tollerabile la rende anche una saggezza imperfetta.
Mantenere i propositi fatti richiede più impegno che concepire onesti propositi.
La filosofia non è un’arte che cerca il favore popolare e non è fatta per essere ostentata; non consiste nelle parole, ma nei fatti.
La filosofia insegna ad agire, non a parlare, ed esige che si viva secondo le sue leggi, perché la vita non sia in contrasto con le parole, né con se stessa, e tutte le nostre azioni si uniformino a un unico principio.
È già molto non essere corrotti dal contatto con la ricchezza; è grande chi ci vive in mezzo da povero.
Se vuoi liberarti da ogni preoccupazione, pensa che avverrà senz’altro quello che temi e, qualunque sia quel male, misuralo con te stesso e poi valuta attentamente la tua paura: sicuramente ti renderai conto che il male temuto o non è grave o non durerà a lungo.
Ti stupisci come di un fatto inaudito, perché, pur avendo viaggiato a lungo e in tanti posti diversi, non ti sei scrollato di dosso la tua tristezza e il tuo malessere spirituale? Devi cambiare animo, non cambiare cielo.
Bisogna vivere con questa convinzione: non sono nato per un solo cantuccio, la mia patria è il mondo intero. …
Prima di proseguire nella lettura della seconda parte di questa “Raccolta di aforismi” tratti dalle Lettere a Lucilio è necessario fare chiarezza e mettere in evidenza quali sono i punti salienti del pensiero di Lucio Anneo Seneca che è l’esponente più autorevole della Scuola filosofica romana di impronta stoica.
Prima di entrare nell’argomento specifico probabilmente è doveroso ricordare brevemente alcuni dati riguardanti l’origine e l’evoluzione del pensiero stoico.
Il pensiero dello “stoicismo delle origini” noi lo abbiamo studiato [insieme con il pensiero “epicureo” e “scettico”] nel corso del nostro primo viaggio sul territorio dell’Ellenismo, nell’anno 2009-2010, e chi lo desidera può usufruire dell’ascolto delle Lezioni di questo Percorso collegandosi sulla rete ai siti di riferimento di questa nostra esperienza didattica: www.inantibagno.it e www.scuolantibagno.net.
Il termine “stoico” deriva dalla parola greca “stoà” che significa “portico”, ed è doveroso ripetere [per rinfrescarci la memoria e per chi non sa] – che nell’anno 300 a.C., sei anni dopo la fondazione del Giardino [o dell’Orto] di Epicuro, un mercante nato nella città di Cìzio, un’antica colonia fenicia sull’isola di Cipro, di nome Zenone [332-264 circa a.C.] apre ad Atene un nuova Scuola. Zenone di Cìzio, per l’attività della sua Scuola, affitta un portico, in greco “stoà”, e questo portico non è un posto qualunque: è il portico del mercato centrale di Atene chiamato Pecile, ed è uno spazio molto bello perché è tutto affrescato dai dipinti di uno dei più importanti pittori dell’antichità: Polignoto di Taso. I tre personaggi principali [i soci fondatori che hanno agito in modo autonomo l’uno dall’altro] attraverso i quali si è sviluppata in origine [nel III secolo a.C.] la Scuola stoica sono Zenone di Cìzio [332-264 circa a.C.], Cleante di Asso [vissuto nel III sec. a.C.] e Crisippo di Tarso [280-209 a.C.] : nel corso del viaggio dell’anno 2009-2010 abbiamo incontrato e studiato il pensiero di questi personaggi. Il pensiero della Scuola stoica ha avuto, insieme con l’epicureismo e lo scetticismo, una grande diffusione nel mondo greco e latino e ha contribuito – per le novità che porta con sé – a dare inizio alla fine dell’Età antica.
Per circa cinque secoli le opere del pensiero epicureo, scettico e stoico [le Scuole di pensiero della “sapienza poetica ellenistica] sono state studiate e dovunque sono sorte Scuole: in Grecia, in Asia Minore, in Egitto e naturalmente anche in Italia, in particolare nella Mega Hellas, nella Magna Grecia. In Italia, nella Campania Felix, il pensiero epicureo insieme al pensiero stoico lo ha portato, nel I secolo a.C., Filodèmo di Gàdara il quale apre una Scuola ad Ercolano, e come sappiamo ad Ercolano, negli scavi di questa città sepolta, come Pompei, dalle ceneri del Vesuvio nel 79 d.C., nella Villa di Calpurnio Pisone [il nobile che ha diretto nel 64 la sfortunata congiura contro Nerone nella quale è coinvolto anche Seneca, con altri intellettuali che incontreremo], ancora oggi tornano alla luce i papiri di un’opera di Filodèmo che s’intitola Rassegna dei filosofi. Un frammento di quest’opera – tra quelli riportati alla luce nel secolo scorso – è molto interessante perché testimonia di come, nel I secolo a.C., le culture epicurea e stoica si diffondano insieme di pari passo nel mondo latino. Leggiamo che cosa scrive Filodèmo di Gàdara nell’opera intitolata Rassegna dei filosofi: «L’amicizia viene distrutta da chi considera la politica un affare e non una missione, e per costoro l’invidia, la rivalità, la lotta, la deliberata organizzazione di guerre sono metodi di lavoro. I filosofi della nostra Scuola hanno per la giustizia, la bontà, la bellezza e le virtù in genere, le medesime inclinazioni delle persone comuni, ma, a differenza di loro, i nostri ideali non sono fondati su basi emotive, cioè sulle degradanti passioni, ma su basi razionali, cioè sulle necessarie e feconde riflessioni. Io penso che queste idee dei discepoli del Giardino [di Epicuro] siano condivise anche dai discepoli della Stoà». Questo frammento mette in evidenza come, già dal I secolo a.C., la Scuola epicurea e la Scuola stoica cerchino e trovino, sul territorio latino della Campania Felix, punti di contatto: il primo ideale comune è quello di fondare una morale basata sulla “ragione” e non su “basi emotive” e, di conseguenza, è logico che come l’epicureo Filodèmo di Gàdara nel I secolo a.C. fa riferimento al pensiero stoico così lo stoico Lucio Anneo Seneca nel I secolo d.C. compone opere nelle quali c’è un costante riferimento a concetti epicurei soprattutto nelle Lettere a Lucilio.
REPERTORIO E TRAMA ... per dieci minuti al giorno di lettura e di scrittura:
A proposito delle “Lettere a Lucilio” e della “Raccolta di aforismi” di cui abbiamo letto la prima parte e stiamo per leggere la seconda: scegliete almeno tre, non più di tre, tra queste sentenze, quelle che ritenete più significative e scrivetele per metterle in circolazione attraverso la biblioteca itinerante …
E ora leggiamo la seconda parte della “Raccolta di sentenze” tratte dalle Lettere a Lucilio: questi aforismi suggeriscono una riflessione sulla condizione umana: sono [abbiamo detto] affermazioni aperte all’interpretazione personale perché la traduzione che Seneca fa della dottrina stoica è decisamente interlocutoria.
LEGERE MULTUM….
Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio [Epistulae morales ad Lucilium]
Raccolta di aforismi come spunti per riflettere sulla condizione umana …
L’arciere non deve colpire il bersaglio di quando in quando, ma deve sbagliare solo di quando in quando; non è un’arte quella che arriva allo scopo per caso.
Un pilota abile naviga pure se la velatura è a brandelli e, se ha perso le sartie, segue ugualmente la rotta con quel che resta della nave.
Quando la morte è vicina e destinata ad arrivare in ogni caso, richiede una fermezza d’animo tenace che è piuttosto rara e la può dimostrare solo la persona saggia.
La vecchiaia segue la giovinezza, e la morte la vecchiaia. Se uno non vuole morire, non vuole vivere.
Qualcuno va incontro alla morte pieno d’ira: solo chi vi si è preparato a lungo, ne accoglie lieto l’arrivo.
Uno solo è il bene, causa e fondamento della felicità: la fiducia in se stessi.
Bisogna cercare un bene che non si guasti giorno per giorno, che non conosca ostacoli. Qual è? Lo spirito, ma deve essere retto, onesto, grande.
La vita è tanto breve, e noi la rendiamo ancora più breve con la nostra incostanza, ricominciandola di continuo ora in un modo, ora in un altro: la riduciamo in pezzi e la laceriamo.
Non è bella la donna di cui si lodano le gambe o le braccia, ma quella la cui bellezza nel suo insieme distoglie dall’ammirare le singole parti.
Non scopriremo mai niente, se ci accontentiamo delle scoperte già fatte.
Se uno segue le orme di un altro, non trova niente, anzi neppure cerca.
Chi è amico ama, ma chi ama non sempre è un amico; e pertanto l’amicizia giova sempre, l’amore, invece, può a volte anche nuocere.
Non puoi sfuggire al destino, puoi solo vincerlo.
Se vuoi sottomettere a te ogni cosa, sottomettiti alla ragione; farai da guida a molti se la ragione farà da guida a te.
La qualità migliore di una persona generosa è l’istinto al bene. Nessuna persona di spirito elevato si compiace di cose abiette e sordide: la attira e la esalta la bellezza delle cose grandi.
Un animo grande disprezza la grandezza e preferisce la moderazione agli eccessi; quella è utile e vitale, questi, invece, nuocciono, proprio perché sono superflui.
Alcuni si immergono nei piaceri e, abituatisi, non ne possono più fare a meno e sono davvero infelici perché arrivano al punto che per loro il superfluo diventa necessario. Non godono dei piaceri, ne sono schiavi.
L’eloquenza povera e scarna rende gli ascoltatori meno attenti: la lentezza e le frequenti interruzioni annoiano; tuttavia, un discorso che si fa attendere rimane più facilmente impresso di uno che scorre via veloce.
Come alla persona saggia si addice un incedere contegnoso, così le si addice un eloquio cauto, e non avventato.
L’essere umano è un animale dotato di ragione: il suo bene lo attua appieno, se adempie al fine per cui è nato. Che cosa esige da lui questa ragione? Una cosa facilissima: che viva secondo la natura che gli è propria.
La punizione più grande per l’individuo perverso consiste nel dispiacere a sé e ai suoi.
I vizi di molta gente rimangono nascosti perché sono deboli; quando avranno forze sufficienti, la loro audacia sarà pari a quella dei vizi che la prosperità ha reso già manifesti.
La nostra insensatezza è evidente: secondo noi compriamo unicamente ciò per cui sborsiamo del denaro, e definiamo gratuito quello per cui paghiamo di persona.
Nessuno può vivere felice se bada solo a se stesso, se volge tutto al proprio utile: devi vivere per il prossimo, se vuoi vivere per te.
Il tempo scorre velocissimo e ce ne accorgiamo soprattutto quando guardiamo indietro: mentre siamo intenti al presente, passa inosservato, tanto vola via leggero nella sua fuga precipitosa.
Quanto è insensato l’oratore che si allontana felice per gli applausi di un pubblico ignorante! Perché ti rallegri di essere lodato da persone che non puoi a tua volta lodare?
Perché nessuno ammette i propri difetti? Perché vi è ancora immerso: i sogni li racconta chi è sveglio e così i propri vizi li ammette solo chi è guarito.
Ecco una gran cosa, avere la debolezza di un essere umano e la tranquillità di un dio.
Crediamo che la morte ci segua e, invece, ci ha preceduto e ci seguirà. Tutto quello che è stato prima di noi è morte; che importa se non cominci oppure finisci, quando il risultato in entrambi i casi è questo: non esistere.
Chi ha molto da fare non ha tempo di abbandonarsi alla dissolutezza. Senza dubbio il lavoro cancella i vizi generati dall’inerzia.
Se il corpo non assolve più le sue funzioni, non è meglio liberare l’anima dalle sue sofferenze? E forse bisogna agire un po’ prima del dovuto perché, arrivato il momento, non ci si trovi nell’impossibilità di farlo; il pericolo di vivere male è maggiore del pericolo di morire presto.
L’animo della persona saggia è come il mondo sulla luna: là c’è sempre il sereno.
Infelice non è chi esegue un ordine, ma chi lo esegue contro la propria volontà. Disponiamoci perciò a volere quello che le circostanze esigono.
Godiamo avidamente della presenza degli amici, perché non sappiamo per quanto tempo ci possa toccare.
È proprio una vergogna per un individuo assennato che il rimedio al dolore sia la stanchezza di soffrire: è meglio che sia tu a lasciare il dolore, non il dolore te.
Non c’è età più adatta alla saggezza di quella che è arrivata al dominio di sé attraverso svariate esperienze, dopo lunghi e frequenti pentimenti.
“Che cos’è, dunque, la ragione?” È l’imitazione della natura. “Qual è il sommo bene dell’essere umano?” Comportarsi secondo natura.
Tutti muoiono nel giorno stabilito dal destino. Non perdi nulla del tempo che ti è stato assegnato; quello che lasci non ti appartiene.
Non sempre la vita va conservata: il bene non consiste nel vivere, ma nel vivere bene.
La persona saggia vivrà non quanto può ma quanto deve. E considererà dove vivere, con chi, in che modo, e quale attività svolgere. Ella bada sempre alla qualità, non alla lunghezza della vita.
Non importa morire presto o tardi, ma morire bene o male; morire bene significa sfuggire al pericolo di vivere male.
Una vita più lunga non è necessariamente migliore, ma una morte attesa più a lungo è senz’altro peggiore.
Ecco l’unico motivo per cui non possiamo lamentarci della vita: non trattiene nessuno.
La condizione della persona poggia su buone basi: nessuno è infelice se non per sua colpa. Ti piace vivere? Vivi; se no, puoi tornare da dove sei venuto.
È cosa iniqua non stendere la mano verso chi è caduto.
L’unico bene è l’onestà, gli altri sono beni falsi e fittizi. …
E ora dobbiamo fare chiarezza sugli elementi fondamentali del pensiero filosofico di Lucio Anneo Seneca anche per capire che lo “stoicismo” della Scuola filosofica romana non si presenta come una corrente dottrinaria ben strutturata che agisce per avere successo nella società ma piuttosto come un movimento intellettuale di carattere pedagogico che vuole insegnare uno stile di vita che possa cambiare la società perché alternativo a quello convenzionale e utilitaristico dettato dal regime imperialista.
Lucio Anneo Seneca aderisce con convinzione alla dottrina della Scuola stoica ma tende – secondo il carattere pratico romano – a modificarne le regole che, essendo troppo rigide, rischiano di diventare un ostacolo e non una via per raggiungere gli obiettivi educativi che lo Stoicismo tardo-antico si propone. La Scuola stoica propone un programma di studio che ha come obiettivo la formazione della persona “saggia”, ed è “saggia” la persona che si lascia guidare dalla ragione e non dalla passione. Seneca si occupa poco di logica [di come funziona la conoscenza del Mondo] e poco di fisica [di come è fatto l’Universo] ma privilegia l’etica, cioè la disciplina che insegna a vivere in modo virtuoso, e la virtù, secondo la Scuola stoica, consiste nel «vivere secondo la natura» e anche nel «vivere secondo la ragione» e anche nel «vivere coerentemente con se stesse e con se stessi».
Seneca afferma che queste tre formule – lo stoicismo originario si differenzia in tre correnti [Zenone di Cìzio, Cleante di Asso e Crisippo di Tarso] – sono in integrazione tra loro perché sostanzialmente si equivalgono in quanto la Natura è retta dalla Ragione divina [il Logos, in greco, che in latino diventa il Verbum], di cui la nostra anima immortale è come una scintilla. Secondo la Scuola stoica è bene, è utile ed è necessario riconoscere la legge fatale dell’Universo [imparare a vivere secondo natura] e adattarvisi [con l’ausilio della ragione, facendosene una ragione] e Seneca aggiunge che “vivere con coerenza” significa trovare il giusto equilibrio tra le esigenze inesorabili della natura e quelle ponderabili della ragione evitando le forzature tanto del naturalismo quanto del razionalismo, quindi, il perimetro dell’esistenza umana è come se avesse la forma di un triangolo i cui vertici sono: la natura, la ragione e l’anima. Per Seneca la Scuola deve proporre un percorso di studio attraverso il quale ogni persona impari a vivere secondo natura [rispettando la Natura], impari a operare secondo ragione [sapendo che l’Intelletto sa distinguere il Bene dal Male] e imparando a prendersi cura della propria anima per avvicinarsi il più possibile alla condizione di grazia in cui si trova l’Essere divino che gli stoici chiamano il Sommo Bene o la Suprema Ragione. Il percorso educativo proposto dalla Scuola stoica serve per forgiare l’animo della persona che deve diventare fermo e imperturbabile, capace cioè di frenare l’ira, di essere clemente e di elargire benefici a tutti, specie agli indigenti.
Più che “sopprimere le passioni” Seneca afferma che “dobbiamo imparare a trasformarle in bene”, pensando che “la malvagità non deve essere odiata, ma vinta da una tenace e costante bontà”. La filosofia di Seneca ha un carattere prevalentemente pratico in quanto l’etica e la pedagogia hanno un posto preminente rispetto alla logica e alla fisica che si basano sul metodo deduttivo [che procede dal particolare all’universale] mentre Seneca vuole valorizzare il metodo intuitivo che, arricchito da validi esempi, mira a insegnare non per la scuola [non per produrre dei saccenti], ma per la vita [per formare persone sagge].
In campo metafisico Seneca parla dell’esistenza di Dio e lo considera non solo fattore del mondo ma anche presente e vivo in ogni persona, non si deve però pensare a un concetto cristiano della divinità intesa come Provvidenza perché non è un Dio che, per infinito amore, salva l’umanità, ma è una “figura intellettuale” nella quale l’essere umano si rispecchia per trovare in se stesso la forza e la virtù per riscattarsi dal male commesso: il Dio di Seneca è la proiezione dell’esigenza che ha la persona di purificarsi dal Male che inesorabilmente contamina l’esperienza umana.
Nei confronti del prossimo Seneca ritiene che si debba essere generosi e magnanimi, anche verso gli schiavi che sono da considerarsi nostri amici.
La morte – il trionfo della Morte – è un tema dominante per Seneca che non intende la morte come un annientamento definitivo [come invece pensano gli epicurei] ma come la liberazione dell’anima dal legame corporeo e una rinascita all’immortalità. Questo sfondo religioso dell’eclettismo di Seneca [Seneca fonde insieme le dottrine delle Scuole ellenistiche] ha fatto pensare che il filosofo avesse rapporti con il movimento cristiano, che si sviluppa in questi anni [dagli anni 50] a Roma intorno alla Sinagoga, e in particolare con Paolo di Tarso: al di là di ogni congettura più o meno leggendaria [di cui ci occuperemo la prossima settimana] resta però il fatto che lo stoicismo di Seneca è realmente pervaso da un afflato religioso simile a quello della primitiva Letteratura dei Vangeli. Inoltre il filosofo predica che la persona, per raggiungere la maturità, deve acquisire quattro virtù: la saggezza, la fortezza, la temperanza e la giustizia ed è significativo il fatto che queste quattro virtù cardinali entreranno, a suo tempo, nel catechismo della Chiesa Universale.
REPERTORIO E TRAMA ... per dieci minuti al giorno di lettura e di scrittura:
Seneca raccomanda di leggere la “Raccolta di aforismi” tratti dalle sue “Lettere a Lucilio” e consiglia di scegliere almeno tre sentenze che, secondo voi, sono da mettere in evidenza, scrivendole e depositandole nella biblioteca itinerante…
Anche la signora Irene Wagner sarebbe tenuta a fare questo esercizio e forse potrebbe trovare il coraggio di ribellarsi visto che si trova proprio nei guai e la sua angoscia sta aumentando: leggiamo, per concludere, questa pagina.
LEGERE MULTUM….
Stefan Zweig, Paura
Da due settimane durava ormai quella lotta interiore, e Irene si sentiva allo stremo delle forze. Erano quattro giorni che la donnaccia non dava segno di sé, ma a tal punto la paura era entrata a Irene nel corpo e le si era fusa con il sangue che, a ogni scampanellio, ella si precipitava di persona alla porta, per intercettare in tempo il messaggio ricattatorio. Nell’udire il campanello Irene si precipitò alla porta: l’aprì e, sulle prime, fu stupita di vedersi davanti una sconosciuta, ma poi, arretrando spaventata, riconobbe nel nuovo abbigliamento e sotto un cappello elegante la faccia odiosa della sua ricattatrice. «Ah giusto lei, signora Wagner, ma che piacere! Devo parlarle di cose importanti». E senza attendere risposta da Irene che, sbigottita, si aggrappava con mano tremante alla maniglia della porta, entrò e posò l’ombrello - un parasole rosso vivo, probabilmente uno tra i primi frutti delle sue estorsioni. Si muoveva con sicurezza inaudita, come fosse a casa sua e, osservando compiaciuta e con un senso quasi di sollievo l’imponente mobilia, avanzò senza esserne invitata verso la porta semiaperta del salotto. «Per di qui, vero?» chiese con sarcasmo rattenuto, e quando Irene tentò di sbarrarle il passo, soggiunse come per tranquillizzarla: «Sbrigheremo la questione al più presto, se la cosa la disturba tanto». Irene la seguì senza replicare. Era come stordita al pensiero che la ricattatrice fosse in casa sua. Le sembrava che tutto fosse un incubo. «È bello qui da lei, molto bello» dichiarò la donna, ammirata e visibilmente a suo agio, mentre si accomodava. «Ah, come si sta seduti bene qui. E quanti quadri. Solo adesso comprendo che vita misera è la nostra. È molto bello qui, signora Wagner». Nel vedersi davanti quell’avventuriera, così comodamente assisa nel suo salotto, la vittima di tanto supplizio ebbe infine un’esplosione di rabbia. «Ma che cosa vuole ancora da me con i suoi ricatti! Mi perseguita fin dentro casa mia. Ma io, da lei, non mi lascerò torturare a morte. Io andrò…». «Non urli tanto» la interruppe l’altra con una familiarità offensiva. «La porta è aperta, e la servitù potrebbe sentirla. Per me, in fondo, fa lo stesso. Non ho proprio intenzione di negare nulla, mi creda, alla fin fine dietro le sbarre non me la passerò peggio che in questa vita da miserabili. Ma lei, cara signora Wagner, lei dovrebbe essere un po’ più prudente. Ma glielo dico subito: gli insulti non mi fanno impressione».
Le energie di Irene, temprate per un istante dalla collera, tornarono ad afflosciarsi di fronte all’imperturbabilità di quell’altra. «Dunque, signora Wagner, non voglio farla tanto lunga. Sono in ristrettezze, questo lo sa. E ho bisogno del denaro per saldare la pigione. Sono in arretrato di parecchio, e poi ho altri pagamenti in vista. Voglio mettere una buona volta un po’ d’ordine nelle mie faccende. Per questo sono venuta da lei, per chiederle un aiuto di …diciamo quattrocento corone».
«Non posso» balbettò Irene, spaventata da quella somma che, in contanti, effettivamente non possedeva. «Non le ho proprio. Questo mese le ho già dato trecento corone. Dove vuole che prenda tanto denaro?».
«Lo troverà di certo. Ci rifletta soltanto. Una donna ricca come lei può avere tutto il denaro che vuole. Ma bisogna volerlo. Ci rifletta dunque, signora Wagner, lo troverà di sicuro».
«Ma non ce l’ho proprio. Se no, glielo darei volentieri».
«E allora cerchi di procurarsele».
«Non posso».
«Be’…ad esempio questo anello. Se lo impegnasse, sarebbe tutto risolto. Naturalmente non m’intendo di gioielli, non ne ho mai avuti, ma quattrocento corone, credo, dovrebbe riuscire a portarle a casa».
«L’anello!» esclamò Irene. Era il suo anello di fidanzamento, l’unico che non toglieva mai e che era di grande valore per via di una gemma molto bella e preziosa. «E perché no? Le mando la ricevuta, così può andarlo a riscattare quando vuole. Lo riavrà indietro. Non lo terrò di certo. Che cosa se ne farebbe una poveraccia come me di un anello così signorile?».
Ma in quel momento udì chiudersi una porta. Doveva essere il marito che tornava dallo studio. Senza riflettere Irene si strappò l’anello dal dito e lo porse alla donna che, ancora lì in attesa, lo fece sparire in fretta. «Non abbia paura. Me ne vado subito» l’assicurò, notando il panico sul volto di Irene e come ella tendesse l’orecchio a quanto accadeva in anticamera, dove già si udiva distintamente un passo maschile. Aprì quindi la porta, salutò il consorte di Irene che stava entrando e che per un istante posò su di lei uno sguardo piuttosto distratto, e scomparve. «Era una signora che voleva un’informazione» così Irene si giustificò con le sue ultime forze, non appena la porta si fu chiusa dietro la donna. Il momento peggiore era superato. Il marito non rispose e passò con tutta tranquillità nella stanza vicina, dove la tavola era già apparecchiata per il pranzo. …
Durante il pasto cercò in continuazione di nascondere la mano, ma ecco che all’improvviso suo marito disse: «Dov’è il tuo anello, oggi?». Lei trasalì. Qualcosa in cuor suo gridò: «È finita!». Ma il suo istinto si difese ancora. «Adesso devi tener duro» le diceva. «E trovare ancora una frase, una parola. Ancora una menzogna, l’ultima».
«L’ho mandato a pulire». E come corroborata da quella bugia, soggiunse risoluta: «Lo vado a riprendere fra due giorni». Fra due giorni. Si era legata con le sue stesse mani, la menzogna sarebbe stata scoperta e anche lei - se non fosse riuscita nell’intento. Lei stessa si era data la scadenza, e la sua paura confusa si compenetrò di colpo con un sentimento nuovo, una sorta di felicità nel sapere che la decisione era ormai vicina. Fra due giorni: adesso conosceva la scadenza, e questa certezza inondava di una strana pace la sua angoscia. Qualcosa cresceva dentro di lei, una nuova forza, la forza di vivere e quella di morire. …
Penso che alla signora Irene – in greco “irene” significa “la pace” – convenga fare il compito [potrebbe trovare consolazione], e penso che suo marito [che appare come una persona molto diligente] stia già eseguendo il compito e immagino che abbia scelto, per prima, questa sentenza: “È cosa iniqua non stendere la mano verso chi è caduto”: questo aforisma trova posto anche nell’Epistolario di Paolo di Tarso.
Che Lucio Anneo Seneca e Paolo di Tarso si siano incontrati a Roma è molto difficile ma non si può escludere e c’è una tradizione letteraria in proposito; sappiamo però che Paolo di Tarso ha degli amici a Roma ai quali, qualche anno prima, ha anche scritto una Lettera e di questa questione ce ne occuperemo nel prossimo itinerario che è l’ultimo dell’anno 2012. La Lettera ai Romani di Paolo di Tarso è un’opera molto importante della cultura tardo-antica che insieme alla Lettere a Lucilio di Seneca fa parte del patrimonio universale della Storia del Pensiero Umano. La Lettera ai Romani di Paolo di Tarso è scritta in greco e si trova conservata nel paesaggio intellettuale dell’Età giulio-claudia: quali sono i temi fondamentali di quest’opera [funzionali al proseguimento del nostro viaggio] e qual è il rapporto culturale tra Paolo di Tarso [l’Epistolario di Paolo] e Lucio Anneo Seneca [le Opere di Seneca]?
Per rispondere a queste domande è doveroso seguire la scia dell’Alfabetizzazione e dell’Apprendimento permanente perché l’Alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune [come il genere letterario degli aforismi] e l’Apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona: per questo la Scuola è qui con il suo carattere “errabondo” perché l’insegnamento più importante è quello che non si acquisisce mai ma che si studia sempre.
Il viaggio continua, e quello della prossima settimana è l’ultimo itinerario prima della vacanza natalizia e l’ultimo itinerario dell’anno 2012: non perdete la celebrazione scolastica del Natale…
